 |
|

| | CORSO
VITTORIO EMANUELE II |
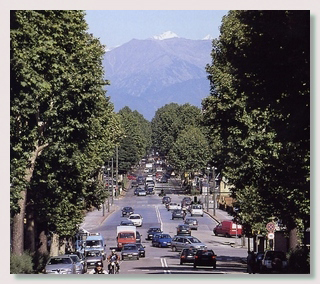
verso le montagne |

all'altezza di Porta Nuova |
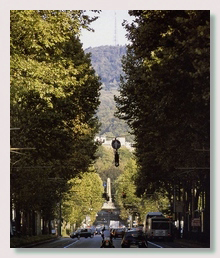
verso la collina |
Il corso inizia dal ponte
Umberto I per finire in corso Francia. Dedicato al «Padre
della Patria», come veniva definito, e, anche al «Re
Galantuomo» è fra tutti i viali torinesi il più
imponente, alberato per gran parte della sua lunghezza. Il
corso è stato tracciato nel XIX secolo, quando la città
ha superato l'antico perimetro delle mura ed ha incominciato
a diventare città industriale. La prima parte dell'arteria,
da Porta Nuova al Po, fu aperta nel 1814 con il nome di corso
del Re poi viale dei Platani, corso di piazza
D’Arme, di S. Avvento. In seguito venne
prolungato verso nord-ovest, in occasione dello sviluppo urbano
progettato dall'architetto Carlo Promis. Fino a Porta Nuova
non ha portici e si incontrano palazzi come il Rossi
di Montelera e il Priotti,
dopo Porta Nuova è
porticata fino a corso Galileo Ferraris dove si incontra il
monumento dedicato al Re

|
|
| | |
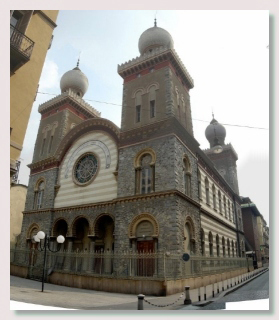 |
Torino ha voluto dedicare questa via
al pontefice Pio V, Antonio Michele Ghislieri, l'unico pontefice
nato in Piemonte (Bosco Marengo 17/01/1504). Via parallela
a corso Vittorio Emanuele II inizia in via Nizza e termina
in corso Massimo d'Azeglio, fu ufficialmente aperta nel 1864,
anche se le prime case vennero edificate a partire dal 1854.
Alla fine dell’Ottocento al numero 11 vi era la casa
degli Angioli Custodi, istituita nel 1857, il cui scopo era
quello di fornire un’istruzione casalinga ed un’educazione
morale e religiosa alle povere giovani raccolte per la strada
e un asilo per una sessantina di lattanti mantenuti grazie
alla beneficenza della contessa Boncompagni nata Pollini.
Via San Pio V è una via dalla tripla anima: case del
dopoguerra e degli anni Sessanta e Settanta nel suo tratto
iniziale (cioè nei pressi di corso Massimo d’Azeglio),
la Sinagoga (che si apre nella pedonalizzata piazzetta Primo
Levi) nel secondo, di nuovo palazzi antichi (che ospitano
bar, ristoranti e locali vari) verso via Nizza. |
|
| | |
 |
Scorre parallela all’ultimo tratto
della ferrovia, quello che porta alla stazione di Porta Nuova,
tra l’incrocio con corso Sommeiller e la confluenza
con corso Vittorio Emanuele. E’ il 26 aprile 1852: durante
i preparativi per il trasferimento in luogo più sicuro
delle regia officina per la fabbricazione delle polveri da
sparo e della raffineria dei nitrati di zolfo, situate nel
cuore del Borgo Dora detto anche Borgo Pallone (da cui il
termine dialettale Balòn), succede l’irreparabile.
All’improvviso, per cause imprecisate, un’ampia
porzione della fabbrica salta in aria insieme a cinque tonnellate
di polvere da sparo, causando la morte di 26 civili. Quasi
tutte le case vicine vanno distrutte, ma la tragedia potrebbe
assumere dimensioni inimmaginabili. Soltanto l’eroismo
del sergente dell’arma di artiglieria Paolo Sacchi,
a capo di un gruppetto di coraggiosi, evita il peggio: costui,
con incredibile eroismo, riesce nell’impresa di isolare
le fiamme dalle centinaia di barili di polvere esplosiva rimasti
intatti.Durante la consegna di una delle tante onorificenze
ricevute. Paolo Sacchi si schernì: “E’
stata la Madonna della Consolata a proteggere la città,
non io”
fonte: La Stampa (Maurizio
Ternavasio) |
| | |
 |
Strada parallela a corso Stati Uniti da
via Sacchi a corso G.Ferraris, diventa corso fino a corso
Castelfidardo. La via e il corso in un quartiere discreto,
fitto di case che risalgono al primo Novecento, sono dedicati
a Rodolfo Gabrielli, conte di Montevecchio, valoroso generale
che prese parte alla guerra di Crimea. |
|
| | VIA
CAMERANA (giÓ del Gazometro) |
 |
Via del Gazometro la si raggiunge
provenendo dalla Strada di Stupinigi e svoltando a sinistra
sul corso Duca di Genova: la prima a destra di quest’ultimo
è proprio via del Gazometro (perpendicolare a via della
Ginnastica), che finisce in corso Piazza d’Armi.
Adesso riscriviamo l’indicazione con la toponomastica
attuale: per andare in via Camerana, nel cuore del quartiere
Crocetta-San Secondo, occorre percorrere via Sacchi in direzione
della stazione, girare a sinistra in corso Stati Uniti e poi
alla prima a destra, che èappunto la via in questione
(perpendicolare a via Magenta), che termina il suo percorso
in corso Vittorio Emanuele II°. Così va meglio,
vero? Passato e presente, insomma. Il passato è quello
del grandioso edificio che, dal 1838, forniva l’illuminazione
a gas grazie all’intraprendenza di una Società
anonima di torinesi e lionesi, che ottennero dal governo e
dall’amministrazione civica la facoltà di illuminare
la città. La via «dove si innalzava l’attuale
fabbricato, chiamato impropriamente Gasometro, che per l’esterna
sua architettura e per la ben intesa distribuzione interna
delle diverse concernenti officine si meritò le lodi
dei visitatori stranieri e nazionali», fu aperta nel
1847.Il presente è invece quello di una arteria ricca
di palazzi di un certo pregio architettonico dalla doppia
anima. Nel primo tratto, quello che collega via Legnano a
via Montevecchio, una serie di edifici ben tenuti, due dei
quali con dei meravigliosi bovindi alla francese. Il secondo,
invece, è un po’ più trasandato, anche
in virtù del continuo via-vai della attigua stazione.
Poche botteghe, la nuova sede dell’ente Bartolomeo &
C, un locale di strip-tease, un paio di ristoranti, un albergo
facente parte di una catena internazionale, un sexy-shop:
queste le attrazioni dell’attuale via Camerana, che
a differenza del secolo scorso inizia in via Legnano, anziché
dall’attuale corso Stati Uniti. Per finire, qualche
notizia sul personaggio cui si deve il toponimo. Giovanni
Camerana, nato a Casale Monferrato nel 1845 e morto a Torino
sessant’anni più tardi togliendosi la vita, fu
un magistrato che ebbe fama in qualità di scrittore
di sensibilità tardoromantica e di critico d’arte
nel periodo della cosiddetta Scapigliatura: il movimento artistico
letterario della seconda metà dell’Ottocento
altro non era che la libera traduzione del termine francese
bohème (vita da zingari), riferentesi alla vita disordinata
e anticonformista degli artisti parigini. Oltre che poeta,
fu anche pittore, e lasciò alcuni nitidi paesaggi che
esprimono soprattutto un’invincibile solitudine.
fonte: La Stampa (Maurizio
Ternavasio) |
|
| | |
|
|
|
Una volta, almeno sino ad
una ventina di anni fa, era sinonimo di prostituzione: “andare
in corso Massimo” era un modo elegante per dire che
si era interessati alla compagnia di qualche passeggiatrice
(eufemismo). All’epoca molti angoli della zona attorno
al corso (via Ormea, via Petrarca, corso Galileo Galilei…)
erano “occupati” da professioniste del sesso itinerante.
Ora il fenomeno si espanso in tutta la città, specie
in periferia, e la fama di corso Massimo d’Azeglio (quartiere
San Salvario-Valentino) è unicamente legata al fatto
di essere uno dei viali più belli di Torino. Il toponimo
lo deve a Massimo Tapparelli dei marchesi di d’Azeglio(Torino,
1798-1866), statista, presidente del consiglio, scrittore
nonché pittore. Inizia in corso Vittorio Emanuele II,
dove c’è il monumento a lui dedicato un tempo
dislocato sulla soglia dei giardini di piazza Carlo Felice,
e finisce in corso Bramante, al di là del quale continua
come corso Polonia. A proposito di monumenti: quasi di fronte
al castello del Valentino vi è quello dedicato a Quintino
Sella, opera del Reduzzi, inaugurato nel 1894. Il corso, che
da un lato costeggia il Valentino, e dall’altro è
ricco di edifici prestigiosi, scorre laddove, sino alla fine
dell’Ottocento, erano dislocate le cascine Ballard,
Olla, Perrone, Maggiordomo, San Paolo, L’ergastolo,
La Passerona: aperta campagna, insomma, almeno nel suo tratto
finale. Vi si alternano costruzioni recenti, comunque di gusto
(ad esempio quelle ai civici 2, 8, 10, 12, 16 e 22) a basse
palazzine ed edifici costruiti nei primi trent’anni
del Novecento: in uno di questi, all’angolo con via
Silvio Pellico, abitò per quasi tutta la vita il noto
sensitivo Gustavo Rol. Al numero 42 sorge l’Istituto
elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris, quello che lancia
il segnale orario a tutta l’Italia. Più avanti
vi è una serie di edifici che ospitano aule e laboratori
della facoltà di medicina. Dopo corso Dante, nell’area
ora occupata dal liceo Alfieri, sino al 1960 vi era la sede
della Società ippica torinese, uno dei capolavori architettonici
di Carlo Mollino.
fonte: La Stampa (Maurizio
Ternavasio) |
|
| | |
 |
E’ una delle vie più chic
di Torino: pochi negozi, ma molte botteghe artigiane di pregio,
gallerie d’arte, laboratori, ristoranti e locali di
tendenza. E, al numero 7 (palazzo
Thaon di Revel), la sede principale dell’Istituto
statale d’arte Aldo Passoni. Via della Rocca, che si
trova nella parte est del centro, congiunge corso Vittorio
Emanuele II con piazza Vittorio Veneto, ed è praticamente
parallela al fiume Po. I suoi palazzi sono di grande pregio
architettonico, specie nel tratto compreso tra via Mazzini
e via Giolitti, ed è conosciuta come la via dei nobili
in virtù delle numerose famiglie patrizie che ci abita(va)no:
se si consulta una guida telefonica della fine degli anni
Sessanta, ci si imbatte nei nomi di Icheri di San Gregorio,
Della Chiesa di Cervignano e Trivero, Biscaretti di Cuffia
Chiò, Radicati di Primeglio, Amari di Sant’Adriano,
Balbiano d’Aramengo…Un po’ di storia, come
sempre. Inaugurata nel 1825, una delle poche vie per le quali
si rinunciò alla linea retta, imprescindibile caratteristica
di quasi tutte le arterie cittadine dell’epoca, prendeva
il nome dalla località, esistente in quella parte dell’agro
torinese, che sin dai tempi più remoti fu denominata
della Rocca in virtù di un piccolo forte con torre,
detto Bastione della Rocca, di cui si hanno notizie sin dal
950. Il sito occupato dal piccolo forte della Rocca funzionò
sino al 1829 come cimitero; nelle immediate vicinanze, nel
1777, vi fu eretta una chiesa dedicata a San Lazzaro. Ecco
alcuni numeri civici della via che hanno fatto (anche) la
storia di Torino: al numero 1 vi morì, nel 1864, l’astronomo
Giovanni Plana, fondatore dell’Osservatorio Astronomico
della città; l’edificio al civico 13 di proprietà
del barone Fedele Claretta, reso suggestivo da un meraviglioso
giardino interno, fu residenza degli ambasciatori di Spagna
e di Napoli, mentre al 14 aveva sede la Società di
scherma e di beneficenza della Guardia Nazionale di Torino,
istituita nel 1850. fonte: La Stampa (Maurizio
Ternavasio) |
|
| | |
|
Il protagonista di questa via: il conte
di Cocconato Napione, di nome Giovanni Francesco, secondo
nome Galleani, nacque a Torino nel 1745. Dopo la laurea in
Giurisprudenza, iniziò ad interessarsi di politica,
ma non solo. Fu presidente del consiglio delle Finanze, animatore
delle accademie cittadine Sanpaolina e Filopatria, coordinatore
di coloro che ebbero l’incarico di riformare l’università
torinese, vicepresidente dell’Accademia delle Scienze,
sovrintendente degli archivi di corte, esperto di architettura
e delle scienze mineralogiche: insomma, una sorta di Pico
della Mirandola tenuto in grande considerazione dalla casa
Savoia. Nel 1812 fu eletto membro della rinata Accademia della
Crusca. Proficua fu pure la sua attività divulgativa
e letteraria: da “Dell’uso e dei pregi della lingua
italiana” a “Vite ed elogi di illustri italiani”,
da “Estratti di opere di grido” a “Lettere
sull’architettura”. Napione morì a Torino
nel 1830, quando ormai la sua figura era assai nota anche
all’estero. La via a lui intitolata, tracciata nel 1825,
si trova in Vanchiglia. Parte da corso San Maurizio, termina
in corso Regina Margherita, e scorre più o meno parallelamente
al Po. Una strada piuttosto trafficata e rumorosa, percorsa
pure dal tram, che nel tratto iniziale, sulla destra, presenta
diverse case di gran pregio, alcune delle quali si affacciano
sul lungopo Macchiavelli. Il numero 2 è occupato dal
museo Casa Mollino, una sorta di esposizione permanente del
grande architetto torinese gestita da Filvio e Napoleone Ferrari.
Fu il pittore Vittorio Avondo a finanziare, con l’ingegner
Bologna, la costruzione di diversi palazzi del quartiere tra
i quali proprio per questo, poi donato alla Società
Piemontese di Archeologia e Belle Arti (fondata a Torino nel
1874) perché ne facesse la propria sede. In via Napione
aveva il negozio (un laboratorio di sviluppo e stampa fotografica)
Arturo Ambrosio, il fondatore della più importante
e prestigiosa casa cinematografica di produzione italiana.
Negli anni Venti, fino alla fine degli anni Cinquanta, in
questa via si trovava uno sferisterio nel quale si giocavano
gli incontri di pallone elastico. In un palazzo dalla doppia
entrata (via Napione e via Bava) ha vissuto negli ultimi anni
della sua breve esistenza Fred Buscaglione, mentre negli anni
Sessanta hanno abitato nello stesso caseggiato, posto all’angolo
con via Santa Giulia, lo scrittore Italo Calvino e l’editore
Giulio Einaudi.
fonte: La Stampa (Maurizio
Ternavasio)
|
|
| | CORSO
REGINA MARGHERITA (giÓ S.Massimo e Santa Barbara) |
|
|
Il corso, lungo quasi 10
chilometri, partendo ad est dal Po attraversa quartieri popolari,
in un alternarsi di vecchie case e di costruzioni nuove, alberato
per lunghi tratti, dal quartiere Vanchiglia, lascia sulla
sinistra i Giardini Reali e le Porte
Palatine, con un tunnel supera Porta Palazzo, attraversa
il quartiere Valdocco dove un tempo vi era il patibolo ( rondò
dla forca) e, superata la ferrovia attraverso un
sottopasso, costeggia il parco della Pellerina per poi terminare
ad ovest nella tangenziale di Torino. Il corso è stato
tracciato nel XIX secolo, quando la città ha superato
l'antico perimetro delle mura ed ha incominciato a diventare
città industriale. É intitolato alla Regina
Margherita di Savoia, prima regina d'Italia(1878). Prima dell’attuale
aveva un altro toponimo, anzi due: sino a piazza della Repubblica
era conosciuto con il nome di corso Santa Barbara, mentre
il secondo tratto era chiamato corso San Massimo. Aperto nel
1818, corso Santa Barbara derivava l’appellativo da
una fontana, posta nelle vicinanze di un’antica cappella,
la cui acqua, fresca e salubre, serviva al bisogno del mercato
di Porta Palazzo. Corso San Massimo invece, inaugurato quattro
anni più tardi, fu dedicato all’omonimo santo,
primo vescovo di Torino, vissuto a cavallo tra il quarto e
il quinto secolo. |
|
|

 
|
|  |
